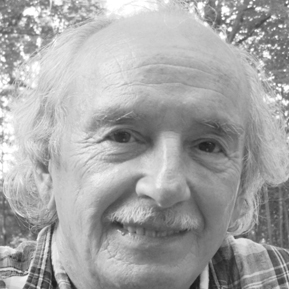Cosa abbia introdotto nelle nostre vite ‒ e cosa continuerà a introdurvi ‒ quell’insieme molto articolato di tecnologie che definiamo digitali, trova oggi una sintesi di fatto nella cosiddetta Intelligenza Artificiale, tematica a un tempo accattivante e inquietante.
Si tratta di qualcosa forse più citato che conosciuto, ma certo pochi di noi trovano ancora sconvolgente l’idea di macchine in grado di compiere azioni e “ragionamenti” complessi, di imparare dai propri errori e di svolgere funzioni fino ad oggi esclusive dell’intelligenza umana. Troviamo da tempo “normale” l’uso quotidiano di strumenti di lavoro che sappiamo avvalersi di sofisticati algoritmi di simulazione e previsione, così come lo sappiamo a proposito di videogames e social media che usiamo nel tempo libero. Nelle occasioni di svago come in quelle professionalmente più cruciali, consideriamo “normale” l’interagire con realtà aumentate e realtà virtuali. Consideriamo “normale” anche il vivere costantemente connessi a una rete sempre più vasta, multimediale, performante e pervasiva, una rete che “arriva alle nuvole”, dove risiedono innumerevoli programmi e immense quantità di informazioni, estraibili da dati di ogni genere, molti dei quali riguardano noi e la nostra sfera privata.
Per usare termini coniati da Luciano Floridi, viviamo ormai nella società matura dell’Informazione, in una sorta di “Infosfera”1 dove gli individui vivono in un fitto reticolo di dati, informazioni, stimoli e azioni, vivono “on-life”, cioè senza più differenza tra on-line e off-line, tra digitale e analogico, tra virtuale e reale.
Anche la pandemia, con le sue drammatiche implicazioni e limitazioni “fisiche”, lo ha reso a tutti più facilmente percepibile: viviamo in un contesto, in un nuovo “ecosistema”, ricchissimo di stimolanti nuove opportunità, anche a riguardo ‒ e non potrebbe essere altrimenti ‒ della possibilità di una diversa organizzazione degli spazi di famiglia e lavoro.
Al contempo, altrettanto indubitabilmente, abbiamo tutti constatato con maggior chiarezza come questo contesto sia anche disseminato di nuovi e forse sottovalutati rischi, dove, con parole di un celebre sociologo e “grande sostenitore della Rete” come Michel Serres, è necessario ed urgente pensare anche la nuova solitudine e la nuova solidarietà2.
Lo sperimentiamo giorno dopo giorno: il nostro è uno spazio-tempo in evoluzione, dove il tempo sembra sempre più comprimersi, dove la famiglia sembra rarefarsi e articolarsi in una pluralità di modi e dove il lavoro si trasforma, sempre più in Servizi, Automazione, Fabbrica 4.0, Telemedicina, Smart Working, Gig Economy3, dove cambiano le competenze richieste in ogni ambito e cambiano le modalità della loro formazione4.
Si rivela d’aiuto nell’inquadrare questo scenario una lettura evolutiva di quanto avvenuto e sta avvenendo in questa nostra era digitale. è la chiave di lettura che proponiamo nella prima delle riflessioni di questo quaderno: partendo dalla Tecnologia per arrivare all’Ecosistema socio-economico in formazione, emerge con estrema chiarezza come il fattore di senso del cambiamento sia il suo protagonista umano, con la conseguente inevitabilità del porre valori culturali e criteri etici a riferimento dell’aumentato potere derivante all’Uomo da questa sua nuova Tecnologia, valori e criteri di cui non sempre si trova coerente traccia nell’odierna quotidianità.
È una chiave di lettura che individua nel tasso esponenziale di sviluppo delle tecnologie digitali una causa ineliminabile della “liquidità” del nostro vivere odierno, così come è declinabile nei suoi svariati aspetti individuali (Persona, Famiglia e Lavoro) e collettivi (Società, Istituzioni Pubbliche e Private, Economia). La conciliazione tra famiglia e lavoro richiede anche il trovare equilibri e in una situazione molto dinamica appare difficile trovare un equilibrio tra variabili in movimento. La complessità del tema è già stata illustrata in vari suoi aspetti, per esempio, nel numero 3 di questa collana dei Quaderni FMV, dal titolo Valutazione delle Best Practices di conciliazione lavoro famiglia e nel supplemento speciale a questo numero dal titolo Corporate family responsibility: un approccio relazionale5.
La tematica può essere affrontata sia in un approccio top-down6 che bottom-up (partendo a scendere da società-istituzioni o a salire da persona-famiglia). Data l’ormai totale pervasività delle tecnologie digitali, ogni approccio porta comunque, di fatto, a toccare “quasi tutto il mondo che ci circonda”, dalla società e dalle sue istituzioni, alle imprese, alla organizzazione delle città, al mondo dei servizi e del lavoro.
Un esempio di strettissima attualità è illustrato nella seconda riflessione di questo quaderno, dove l’avvocato Cinzia Biondi porta in evidenza come lo smart working trovi nella componente tecnologica unicamente il proprio fattore abilitante. La sua piena traduzione in un fruibile progresso dal punto di vista della conciliazione delle esigenze individuali e collettive richiede però non solo un’adeguata formazione delle persone, ma anche il ripensare e regolare in modo anche giuridicamente coerente, in un contesto di articolata complessità, i nuovi processi e modelli organizzativi e normativi aziendali.
La terza riflessione ospitata, che riassume i risultati di una ricerca presso l’Università Sapienza della professoressa Cinzia Daraio e della dottoressa Julia Nawaro, illustra il potenziale delle tecnologie digitali, nello specifico quelle della Data Science, per una più precisa identificazione e quantificazione dei processi sociali che caratterizzano l’evoluzione, per esempio, della struttura familiare, finalizzabili a una migliore capacità di ideare e pianificare i più idonei interventi di sostegno.
Si tratta di benefici previsionali già ampiamente sperimentati in vari contesti imprenditoriali. Ce lo testimonia nell’intervista dedicata alla sua esperienza il dottor Michele Grazioli, presidente e CEO di Vedrai SpA, una iniziativa imprenditoriale giovanile di eccellenza, già riconosciuta a livello internazionale, nata con l’obiettivo specifico di sviluppare ed implementare soluzioni e piattaforme basate su Intelligenza Artificiale, per il supporto a imprenditori e manager nei processi decisionali aziendali. Anche in questo caso viene sottolineata la consapevolezza di come ogni vantaggio acquisito grazie alla tecnologia, per esempio il maggior tempo libero reso disponibile dalla possibilità di standardizzare e semplificare molteplici processi aziendali, si associ al dilemma morale del suo utilizzo: l’ultima parola spetta all’uomo.
Questa consapevolezza di fondo caratterizza anche l’esperienza oggetto della seconda intervista, in cui il professor Francesco Calimeri e l’ingegner Salvatore Ielpa, presidente e fondatore e project manager di DVLSystems, ci illustrano una iniziativa imprenditoriale per l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale dalla più marcata missione sociale, in quanto spin-off dell’Università della Calabria. Sono numerosi, nella loro esperienza, i campi applicativi in cui si trova conferma, oltre che della potenza, anche della non neutralità della tecnologia. Ne consegue la necessità, per ogni suo efficace utilizzo, di poter usufruire di una adeguata squadra di esperti della specifica complessità affrontata, come potrebbe essere nel caso di una diagnostica delle situazioni di disagio familiare.
Il tema della non neutralità della tecnologia, in particolare delle pericolose conseguenze di un suo uso sbagliato o anche solo non adeguatamente curato, emerge con particolare vigore nella terza delle esperienze illustrate in questo quaderno, volutamente dedicata al forse inevitabile carico di sofferenza che ogni cambiamento comporta per i più deboli e i più esposti. Il dottor Gianluca Bolchi ci illustra gli aspetti salienti del suo servizio di neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza presso la ASST Brianza, evidenziando il progressivo e drammatico aumento delle casistiche nell’ultimo decennio e l’esplosione, in questi durissimi anni di pandemia, del numero di casi da trattare. Con la tecnologia si è cercato di ovviare ai distanziamenti fisici, cosa ovviamente dimostratasi possibile; ma questa rivoluzione ha dei prezzi: micro (l’uso quotidiano del lavoro da remoto in situazioni di sofferenza psichica o fisica che necessitano imprescindibilmente di un contatto diretto) e macro (le politiche fortemente discriminanti verso la metà del mondo in grave difficoltà economica).
Un’ulteriore, forse definitiva conferma: in qualunque contesto ci si muova e qualunque sia l’obiettivo perseguito, occorre «imparare a cavalcare l’inarrestabile onda distruttrice e creatrice della tecnologia»7, un invito e una responsabilità cui rafforzate conoscenza, creatività e volontà umane possono dare positiva risposta.
Note
1 Cfr. L. Floridi, Pensare l’infosfera. La filosofia come design concettuale, Raffaello Cortina, Milano 2020.
2 Cfr M. Serres, Dal metodo non nasce niente, Bollati Boringhieri, Torino 2016.
3 Cfr. McKinsey & Company, A government blueprint to adapt the ecosystem to automation and the Future of Work, January 2020.
4 Cfr. G. De Michelis, How Thumbelina Knows, Concept Paper November 2016, DOI:10.3390/informatics3040022.
5 Cfr. G. Vigorelli (a cura di), Valutazione delle Best Practices di conciliazione lavoro famiglia, «Quaderni FMV Corporate family responsibility», luglio 2019 e G. Vigorelli (a cura di), Corporate family responsibility: un approccio relazionale, «Quaderni FMV Corporate family responsibility», novembre 2019.
6 Cfr. M. Barbieri, Welfare aziendale, arriva app per le best practice, «Fortune Italia», 6 settembre 2021. Vi si illustra il progetto ReFlex (Reconciliation and Flexibility: reconciling new work and care) – promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che vede coinvolta anche l’Università Roma Tre e ha come obiettivo finale il “sistematizzare e modellizzare un sistema di welfare aziendale che si ponga in futuro come riferimento nazionale per tutte le imprese”.
7 Invito formulato all’epoca della nomina da Rich Lesser, CEO di Boston Consulting Group dal 2013 a maggio 2021.