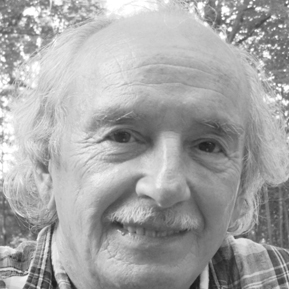1. Introduzione
Nell’arco di una sola generazione di homo sapiens, avvento ed evoluzione delle Tecnologie Digitali hanno innescato cambiamenti, spesso epocali, in quasi ogni aspetto della vita individuale e sociale della grande maggioranza del genere umano.
Un fenomeno dalla dinamica vorticosa, metaforicamente ben resa da una famosa riflessione sul tempo di Sant’Agostino: «… forse sarebbe esatto parlare di presente del nostro passato, presente del nostro presente e presente del nostro futuro»1. Sono gli anni della nostra generazione, quelli che vanno dall’invenzione del transistor, anni cinquanta del XX secolo, all’avvento dell’Intelligenza Artificiale, motore odierno del vero e proprio ecosistema di relazioni digitali in cui tutto e tutti sono costantemente connessi a una Rete Globale che rende disponibili quantità di dati e risorse di calcolo virtualmente illimitate.
2. La Tecnologia Digitale, il fattore abilitante di un processo evolutivo
Siamo ormai entrati nel pieno della Digital Age, l’epoca dell’Information & Communication Techology (ICT), un dominio tecnologico dove la crescita in volumi e prestazioni mantiene da decenni un ritmo vertiginoso.
Nei cinquant’anni in cui la popolazione mondiale è passata da quasi 4 miliardi di individui a quasi 8 (1970-2020), l’ordine di grandezza dei suoi computer è passato dal milione di mainframe del 1970 ai dieci milioni di mini computer nel 1980, ai cento milioni di pc nel 1990; al miliardo di desktop internet nel 2000; ai dieci miliardi di mobile internet nel 2010; ai più di cinquanta miliardi di dispositivi Internet of Things nel 2020.
La potenza di calcolo dei suoi supercomputer è passata dal MegaFLOPS (un milione di operazioni in virgola mobile al secondo) del 1961, al GigaFLOPS (un miliardo di operazioni) del 1984, al TeraFLOPS (mille miliardi) del 1997, al PetaFLOPS (un milione di miliardi) del 2008, allo ExaFLOPS (un miliardo di miliardi) del 2021.
Il tempo di raddoppio dei dati che produce è arrivato oggi a circa un anno: nel 2018 sono stati cioè generati tanti dati quanti ne sono stati generati fino all’anno precedente nell’intera storia dell’umanità (un numero pari a centinaia di Zettabyte, centinaia di migliaia di miliardi di miliardi di byte). Con l’IoT in meno di dieci anni avremo 150 miliardi di sensori connessi in rete, venti volte il numero di persone sulla Terra. Allora la quantità di dati generati raddoppierà ogni 12 ore2.
Siamo davanti alla “Grande Sfida dei Big Data”, quella di «riuscire ad estrarre, con l’aiuto dell’AI, la grande quantità di informazione che fluisce dentro e fuori dai sistemi complessi con cui conviviamo ed entro cui viviamo…»3. Inoltrandoci negli anni Venti del Terzo millennio, ai fini dell’effettivo utilizzo di dati disponibili in quantità finora impensabili, assumerà dunque un ruolo sempre più primario qualcosa, un insieme di cose, che viene identificato con il termine di Artificial Intelligence (AI).
Macchine dotate di AI, cioè della capacità di “apprendere” autonomamente (machine learning, deep learning) e di “relazionarsi” in modalità analoghe a quelle umane (Natural Language Processing, Machine Vision), da qualche anno non sono più solo argomento di ricerca e dibattito; sono diventate una realtà tangibile, forse un po’ abusata in chiave mediatica, delle Tecnologie Digitali, dominio nel quale, per altro, si va già profilando un ulteriore step epocale. è quello legato alla tecnologia del Quantum Computing, dove le leggi della fisica quantistica vengono usate per trasformare i bit in q-bit, bit quantistici, una sovrapposizione di “infiniti” stati tra 0 e 1 intrinsecamente correlati con quelli di altri q-bit.
I computer quantistici sono già una realtà a livello pioneristico; col tempo permetteranno di archiviare e manipolare enormi quantità di dati e di elaborarli con la potenza di calcolo di un odierno supercomputer, ma usando meno energia di un computer tradizionale. Con simili strumenti verranno risolti in pochi minuti problemi che oggi richiedono anni di elaborazione, troveranno soluzione problemi oggi irrisolvibili, e diverrà più difficile risolvere la potenziale inesplicabilità delle “scelte” operate dalle reti neurali artificiali.
Ancora una volta, è l’intero scenario evolutivo delle tecnologie digitali a presentarsi a un tempo affascinante e inquietante, visto come ne è sempre più condizionato l’intero progresso dei vari campi della conoscenza e dell’operare umano, anche per il peso assunto dalle odierne scienze della complessità sia nell’ambito delle scienze naturali sia in quello delle scienze umane e sociali. La “digitalizzazione” favorisce inoltre la tendenza per tecnologie originariamente non correlate a “convergere”, a diventare cioè più strettamente integrate e persino a unificarsi man mano che si sviluppano e progrediscono.
Le anticipazioni su questi temi hanno sempre sapore vagamente fantascientifico, ma abbiamo già tutti avuto modo di sperimentare, nella quotidianità della nostra vita, con quale rapidità il successivo avvento di personal computer, internet, smartphone, social network, abbia rivoluzionato il nostro operare e il nostro interagire a ogni livello, da quello personale, a quello familiare, a quello lavorativo, a quello sociale.
In ognuno di questi ambiti ci siamo abituati, progressivamente ma sempre più velocemente, a cose dal nome più o meno evocativo, come e-Commerce, Full Mobility, Individual Enterprise, Virtual Reality… ci stiamo abituando a Internet of Things, Advanced Automation, Augmented Reality, Blockchain, Cybersecurity, Non-fungible Token … ci abitueremo, molto presto, a vivere in un mondo “sempre più smart”, fatto da Smart Homes, Smart Cities, Smart Industries, Smart Services…
Le Tecnologie Digitali, in estrema sintesi, hanno reso possibile – abilitandole con piattaforme di socialità e lavoro sempre più evolute – la trasformazione e la reinvenzione delle logiche relazionali e operative dell’ecosistema socio-economico cui apparteniamo e anche la sua interazione con ogni altro ecosistema dell’intero pianeta. E continueranno a farlo.
3. Ecosistemi evoluti, il risultato emergente del processo
La metafora dell’ecosistema ha trovato progressiva applicazione, sia in informatica che nelle discipline socio-economiche, nella descrizione dei sistemi in continua evoluzione dove ogni entità deve essere flessibile e adattabile per sopravvivere, come in un ecosistema biologico. L’espressione “Ecosistema aziendale” ben si presta, per esempio, a caratterizzare le reti di organizzazioni (fornitori, distributori, clienti, concorrenti, agenzie governative e così via) coinvolte nella fornitura, attraverso la concorrenza e la cooperazione, di uno specifico prodotto o servizio.
Le reti di relazioni di qualunque natura sono oggi sempre più basate sull’utilizzo di piattaforme informatiche, cioè di gruppi di tecnologie utilizzate come base per sviluppare più agevolmente altre applicazioni, processi o tecnologie. Le soluzioni basate su tecnologie digitali si stanno per esempio dimostrando gli strumenti più potenti ed economici, tra i vari a disposizione di una città, per la costruzione di un futuro più vivibile. In tutto il mondo le città si vanno trasformando in cosiddette Smart City con l’evoluzione, a vari livelli, delle loro tradizionali infrastrutture fisiche e sociali4.
La trasformazione in questa direzione di un “ecosistema città” si traduce in ovvii benefici, come una maggiore efficienza e minori costi per gli operatori del settore pubblico e una maggiore produttività per gli operatori del settore privato di mercato. Fatto non marginale, si traduce anche in aumentate possibilità di conoscenza, interazione ed azione per gli operatori del Terzo settore.
Come teorizzato dallo storico della tecnologia Melvin Kranzberg, però, se la tecnologia non è né buona né cattiva, neanche è neutrale. Cogliere nella loro pienezza le opportunità abilitate dalle innovazioni richiede anche un’adeguata gestione di tutte le implicazioni della loro adozione.
Un esempio emblematico può essere il cosiddetto Smart working, nella sua accezione volgarizzata di lavoro a distanza. Durante la pandemia, la scoperta, o meglio la conferma, della sua assoluta applicabilità a moltissime attività lavorative ha portato in evidenza anche la complessità del riuscire a garantire, al contempo e a ciascuno, la salvaguardia di bisogni complementari come la propria “privacy” e il bisogno di socialità “fisica”. Stiamo ora assistendo al conseguente processo di assestamento differenziato per settori e alla necessaria regolamentazione di un futuro “ibrido” per il lavoro. La tematica generale della non neutralità della tecnologia è ben sviluppata anche in un recente lavoro di Mei Lin Fung e Deborah Gale, dove si illustra come la “Home”, la nostra casa, sia passata dall’essere quel “rifugio e spazio del nostro privato”, che a lungo è stata nell’epoca moderna, all’essere, grazie alle tecnologie digitali, il “primo luogo di accesso e incontro con il mondo intero”, nel bene e nel meno bene5. Un ruolo che ben giustifica l’attenzione e la cura che l’appropriato utilizzo della tecnologia ci richiede, per esempio per evitare una comprensione e un controllo solo parziali del come dati ed informazioni sono usati, per quali scopi e a beneficio di chi.
«Dobbiamo imparare a cavalcare l’inarrestabile onda distruttrice e creatrice della tecnologia» è l’invito formulato all’epoca della nomina da Rich Lesser, CEO di Boston Consulting Group dal 2013 a maggio 2021. Si rivela sempre più attuale, evidenziando della tecnologia sia la pervasività tipica dell’acqua (arriva ovunque) sia la coesistenza di luci ed ombre nel suo affermarsi: distrugge, crea e trasforma, in meglio oppure no.
Il frangente storico della pandemia ha confermato il ruolo primario che la tecnologia digitale può assumere nell’aiutare la difesa della vita delle persone e nel favorire il conciliare positivamente i vari ambiti in cui si sviluppa (salute, famiglia, lavoro, socialità).
Al tempo stesso ha accentuato le preoccupazioni relative agli impatti occupazionali associabili alla prevista ulteriore automazione delle attività produttive e all’associato radicale cambiamento dello skill mix richiesto6.
A ben guardare, «interi paesi hanno fatto da cavie in esperimenti sociali su larga scala, come il lavorare tutti da casa o il comunicare solo a distanza, come avere un intero sistema scolastico o universitario alimentato solo on-line. Si tratta di esperimenti che nessuno accetterebbe mai di condurre in tempi normali. È in fondo la vera implicazione delle emergenze globali: accelerano i processi storici»7.
4. L’Uomo “aumentato”, centro del processo e senso dell’evoluzione
Il fatto che alle fonti dell’attuale processo evolutivo sia facilmente individuabile il fattore tecnologico e che il processo stesso sfoci in un nuovo ecosistema tende a mantenere in ombra, forse anche perché dato per scontato, quale sia in realtà il “baricentro”, il “fattore di senso” dell’intero processo.
Il ruolo della persona viene spesso implicitamente associato ai ruoli classici di “produttore” e di “consumatore” caratteristici dell’attuale modello di sviluppo socio-economico. In tale rappresentazione, entrambi i ruoli richiedono unicamente, anche se non banalmente, interventi di ulteriore formazione/informazione relativi a nuove competenze tecnologiche del “fattore umano”.
Questa rappresentazione lascia anche spazio a ipotizzare come possibile “baricentro finale” del processo di cambiamento qualche forma non meglio qualificata di “intelligenza artificiale”, capace di superiori prestazioni e in grado quindi di sostituire l’intelligenza e la volontà umana nell’efficientare l’ecosistema. Come dire, la possibilità per le macchine di assumere potere di indirizzo, controllo e governo di un ecosistema di cui l’uomo è parte subordinata.
Le considerazioni al riguardo non possono che partire da quello che i calcolatori fanno per certo: elaborano informazioni (cioè numeri e parole) secondo istruzioni algoritmiche (i programmi). Forniscono risposte alle domande loro poste, nell’ambito di regole definite dagli umani a volte in modo esplicito, a volte in modo sottilmente implicito (per esempio attraverso ontologie definite sui domini di conoscenza dei sistemi AI). Sono quanto di più razionale si possa immaginare e, vedasi la legge di Moore, non sembrano avere limiti nel poter esercitare una sempre più vasta e rigorosa razionalità sulla base di informazioni disponibili in quantità e qualità sempre maggiori.
La razionalità è una delle caratteristiche dell’intelligenza umana (anche se ben lungi dall’essere esaustiva delle sue molteplici caratteristiche) e i sistemi di apprendimento artificiale più recenti già si dimostrano superiori in molte attività una volta considerate prerogativa di una superiore intelligenza umana, come giocare a scacchi o a “Go”.
Resta però il fatto che l’applicabilità dei sistemi basati sull’AI è ancora piuttosto… ristretta. I sistemi di machine learning sono addestrabili a svolgere (molto bene) compiti specifici, ma la loro “intelligenza” non può, anche nel caso delle promettenti e ancora in parte misteriose reti neuronali, generalizzare la “conoscenza” acquisita ad altri domini, cosa che invece sa fare, in modo del tutto naturale, una persona che ha imparato a eseguire bene un dato compito.
Siamo ancora molto lontani dall’avere macchine che possano veramente esibire un’intelligenza generalizzata in domini diversi. Possiamo dunque trarre una prima conclusione: in un certo qual senso e relativamente all’ambito della razionalità, più che di una “Intelligenza Artificiale” con cui competere, disponiamo ormai di una “Intelligenza Aumentata” da usare in modo selettivo.
Una narrazione precisa del cambiamento epocale in essere vede allora una chiara identificazione del fattore tecnologico come fattore abilitante, cioè non come fine della trasformazione e nemmeno (almeno in prima istanza) come mezzo. Il fattore tecnologico abilita solo la costruzione del vero “mezzo” per la trasformazione, che sono nuovi e più potenti strumenti utilizzabili dalle persone in chiave di “Augmented Intelligence”.
È cioè la persona a diventare in questo modo al tempo stesso “padrone” (nel senso di chi padroneggia) di nuove competenze (nel senso di capacità) e fruitore (nel senso di chi beneficia) di nuove esperienze (nel senso di assegnazione di valore al proprio vissuto).
Sono queste aumentate potenzialità ed esperienze della persona, dell’uomo, il vero “baricentro iniziale e finale” del cambiamento che sfocia in un nuovo ecosistema, ambito di emergenza di nuovi modelli di business, di nuovi modelli d’impresa, perfino di nuovi modelli di sviluppo, così come “costruiti” da umana volontà e intelligenza. Nel bene o nel male.
In parole più evocative, in un Mondo nuovo, la Tecnologia in un certo senso torna al vecchio: riporta l’Uomo al centro, dopo averlo ulteriormente potenziato con nuovi strumenti di conoscenza e azione. Ciò significa che continueranno a essere essenziali imprenditori, innovatori, scienziati, creativi, manager… e persone, padri, madri… che identificano quale nuovo problema affrontare, o quale opportunità perseguire, o quale nuovo territorio esplorare. C’è un’enorme differenza tra il saper valutare, passivamente, lo stato mentale o morale di qualcuno – cosa che le macchine possono oggi fare – e il poter operare, attivamente ed efficacemente, per cambiarlo usando pulsioni sociali di volta in volta condivisibili, come compassione, orgoglio, solidarietà, vergogna… per persuadere, motivare, ispirare. Nell’era dell’AI – dove l’importanza non emulabile dell’intelligenza umana emerge all’intersezione di due necessità, capire su quale prossimo problema od opportunità lavorare e persuadere quante più persone a lavorarci per risolverlo o per coglierla – solo un principio generale è chiaro: nel prossimo decennio, nel presente del nostro futuro, l’AI non sostituirà i manager; ma i manager che utilizzano l’AI, in qualunque settore operino, sostituiranno quelli che non lo faranno. Perché solo loro saranno in grado di estrarre al meglio valore dai dati, con un processo che si può così sintetizzare: dai Dati all’Informazione alla Conoscenza al Saper Fare8.
Il che non significa affatto sostituire con relazioni tecnologiche, più facilmente usabili a fine manipolativo, le tradizionali relazioni umane, indispensabili con la loro ricchezza nel «… cercare fondamenta migliori per costruire società inclusive, giuste, solidali, capaci di restituire dignità a quanti vivono in grande incertezza e non riescono a sognare un mondo migliore»9.
Nella logica di un umanesimo digitale, è l’uomo ad essere “aumentato” dalla tecnologia nella interezza delle sue dimensioni, individuali e sociali, e rimane in particolare impossibile, lo si voglia o meno, prescindere da valutazioni di natura etica, o meglio etica e antropologica10, per poter passare dalle logiche passive di un mondo “VUCA” (quello attuale, caratterizzato da volatilità, incertezza, complessità, ambiguità) alle logiche di costruzione di un Ecosistema Integrale (un mondo caratterizzato dalla piena sostenibilità ambientale e socio-economica del modello di sviluppo).
Come ricordava Karl Popper: «Il futuro è aperto, dipende da noi. Dipende da come vediamo il mondo e valutiamo le possibilità di futuro che sono aperte».
Note
1 Agostino, Confessioni, XI, 20, 26. 1
2 Mario Rasetti, Il dado è tratto. Big Data e IA tra scienza e società, DOI: 10.23801/ asimmetrie.2019.27.1
3 Mario Rasetti, Intelligenza Umana vs. Intelligenza Artificiale: c’è una competizione in corso, presentazione a evento Club Dirigenti Tecnici, Torino 2019.
4 Si veda, ad esempio, lo studio Smart Cities: Digital Solutions for a more livable Future, McKinsey Global Institute, June 2018.
5 Mei Lin Fung e Deborah Gale, Digital Home: The Missing Element for a People-Centered Digital Future, in A. Argandoña, J. Malala, R. Peatfield, The Home in the Digital Age, Routledge 2021.
6 Si vedano, ad esempio, gli studi Skill Shift: Automation and the Future of the Workforce, MkKinsey Global Institute, May 2018 e The Future of Jobs in the Era of AI, Boston Consulting Group–Faethm, March 2021.
7 Ripreso da Y. N. Harari, The world after coronavirus, «Financial Times», March 20th, 2020.
8 Per chi volesse approfondire l’argomento AI, due ottime sintesi disponibili on-line sono: E. Brynjolfsson, A. McAfee, The Business of Artificial Intelligence, «Harvard Business Review», 2107 e M. Chui, B. McCarthy, An executive’s guide to AI, «McKinsey Analytics», 2018.
9 Papa Francesco, Messaggio al Presidente esecutivo del World Economic Forum, 2018.
10 Si veda, ad esempio, Marta Bertolaso e Giovanni Lo Storto (a cura di), Etica digitale. Verità, responsabilità e fiducia nell’era delle macchine intelligenti, LUISS University Press, Roma 2021.
Bibliografia
Marta Bertolaso e Giovanni Lo Storto (a cura di)
2021 Etica digitale. Verità, responsabilità e fiducia nell’era delle macchine intelligenti, LUISS University Press, Roma.
Richard Masland
2021 Lo sappiamo quando lo vediamo. Cosa ci dice la neurobiologia della visione su come pensiamo, Einaudi, Torino.
Rainer Strack et al.
2021 The Future of Jobs in the Era of AI, Boston Consulting Group – Faethm, March 18.
Marco Dondi et al.
2020 A government blueprint to adapt the ecosystem to automation and the Future of Work, McKinsey & Company, February 7| Report.
Ulrich Pidun et al.
2019 Do you need a business ecosystem?, Boston Consulting Group | BCG Henderson Institute, 27 September.
Mario Rasetti
2019 Il dato è tratto – Big data e intelligenza artificiale tra scienza e società, «Asimmetrie.it – Rivista dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare», DOI: 10.23801/asimmetrie.2019.27.1.
Federico Faggin
2018 Silicio. Dall’invenzione del microprocessore alla nuova scienza della consapevolezza, Mondadori, Milano.
Erik Brynjolfsson, Andrew McAfee
2017 The Business of Artificial Intelligence, «Harvard Business Review».